 Clicca qui per leggere l’articolo, pubblicato sul Quotidiano di Puglia del 10 maggio 2019, sul film Il Grande Spirito.
Clicca qui per leggere l’articolo, pubblicato sul Quotidiano di Puglia del 10 maggio 2019, sul film Il Grande Spirito.
Archivi tag: Quotidiano
Marco Schnabl sul Quotidiano
 Clicca qui per leggere l’articolo, apparso sul Quotidiano di Puglia del 19 settembre, sul nuovo album di Marco Schnabl.
Clicca qui per leggere l’articolo, apparso sul Quotidiano di Puglia del 19 settembre, sul nuovo album di Marco Schnabl.
Nessuno scompare davvero: l’intervista a Catherine Lacey
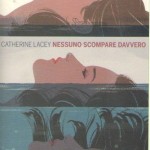 Clicca qui per leggere l’intervista a Catherine Lacey, autrice di “Nessuno scompare davvero” (Edizioni SUR). Articolo pubblicato sul Quotidiano di Puglia del 27 giugno 2016.
Clicca qui per leggere l’intervista a Catherine Lacey, autrice di “Nessuno scompare davvero” (Edizioni SUR). Articolo pubblicato sul Quotidiano di Puglia del 27 giugno 2016.
La “pazza gioia” è donna
 Clicca qui per leggere l’articolo sul film “La pazza gioia” di Paolo Virzì. Pubblicato sul Quotidiano di Puglia il 23 maggio 2016.
Clicca qui per leggere l’articolo sul film “La pazza gioia” di Paolo Virzì. Pubblicato sul Quotidiano di Puglia il 23 maggio 2016.
Taranto da abbracciare. La recensione di “Città nascoste”
 Clicca qui per leggere la recensione di “Città nascoste – Trieste Livorno Taranto” (Exorma), il libro di Paolo Merlini e Maurizio Silvestri, pubblicata sul Quotidiano di Puglia il 20 maggio 2016.
Clicca qui per leggere la recensione di “Città nascoste – Trieste Livorno Taranto” (Exorma), il libro di Paolo Merlini e Maurizio Silvestri, pubblicata sul Quotidiano di Puglia il 20 maggio 2016.
La recensione del nuovo album di Vinicio Capossela
 La recensione di “Canzoni della Cupa”, nuovo album di Vinicio Capossela, pubblicata sul Quotidiano di Puglia del 18 maggio.
La recensione di “Canzoni della Cupa”, nuovo album di Vinicio Capossela, pubblicata sul Quotidiano di Puglia del 18 maggio.
“Belli di papà”: il campanilismo non serve
 Clicca qui per leggere il commento di Giuliano sulla polemica scoppiata a Taranto intorno al film “Belli di papà”. Articolo uscito con richiamo in prima pagina sull’edizione di Taranto del Quotidiano di Puglia del 12 ottobre.
Clicca qui per leggere il commento di Giuliano sulla polemica scoppiata a Taranto intorno al film “Belli di papà”. Articolo uscito con richiamo in prima pagina sull’edizione di Taranto del Quotidiano di Puglia del 12 ottobre.
I talebani dell’ignoranza e la colpevole indifferenza
 L’articolo apparso il 24 marzo sul Quotidiano di Taranto. Riflessioni sugli arredi di un palazzo storico trafugati e bruciati in un falò di San Giuseppe.
L’articolo apparso il 24 marzo sul Quotidiano di Taranto. Riflessioni sugli arredi di un palazzo storico trafugati e bruciati in un falò di San Giuseppe.
Spariamola grossa: gli antichi mobili sottratti da un palazzo nobiliare in Città Vecchia e bruciati nel falò di San Giuseppe fanno (o dovrebbero fare) lo stesso effetto terrificante dell’abbattimento delle statue a Mosul da parte dell’Isis o del rogo di libri a opera dei Nazisti nel 1933. La differenza è una sola: se ad armare la mano di barbuti e camicie nere è stata la fede cieca in principii folli, a casa nostra il delitto non ha alcuna radice ideale. Si è consumato così, senza un vero motivo, forse per pura stupidità. Niente guerre di religione o miti della razza, qui: da noi impera la dittatura dell’ignoranza e dell’incuria. Che forse è ancora peggiore.
Di Taranto vecchia sono i colpevoli dello sfregio, di Taranto vecchia sono anche i ragazzi (dell’associazione Obiettivo Borgo Antico) che l’hanno denunciato. Nell’attribuzione delle colpe non ci aiuta la divisione fra quartieri degradati e “città bene”. Così come false e fuorvianti sono tante divisioni in cui spesso finiamo per cadere: fra ricchi e poveri, fra ladri e onesti, fra destra e sinistra, fra operai e ambientalisti. A Taranto la vera divisione è un’altra. Da un lato ci sono quelli che sanno, e se non sanno si informano. Quelli che alla città tengono, e si danno da fare per difendere il buono che esiste e per costruire qualcosa di nuovo. Dall’altro lato c’è chi non sa, oppure sa e se ne frega, chi distrugge o lascia che vada tutto a rotoli. E se non ha senso fare manichee separazioni fra buoni e cattivi (probabilmente nella maggior parte dei tarantini c’è qualcosa di entrambe le categorie, così come peraltro accade in qualsiasi città) è anche vero che Taranto è in un momento di crisi (che vuol dire anche trasformazione, opportunità). E nelle crisi le posizioni si polarizzano: la gente è chiamata a schierarsi, e non schierarsi vuol dire essere arruolati d’ufficio nell’esercito dei cemmenefuttisti.
Chi sono allora i talebani dell’ignoranza? Innanzitutto chi si è macchiato del misfatto: al netto delle possibili attenuanti (erano ragazzini, non sapevano, nessuno ha insegnato loro ad amare il posto in cui vivono…) un nocciolo di responsabilità individuale va sempre conservato. L’educazione passa anche dalla stigmatizzazione di un comportamento sbagliato. E di comportamenti sbagliati, il giorno di San Giuseppe, ce ne sono stati a bizzeffe (ecco gli altri colpevoli). A partire dalla razzia indiscriminata di legno: rubare materiale da strutture pubbliche o private è un reato anche se non si tratta di arredi del Settecento. Cosa dire poi della totale anarchia in cui vengono accesi i falò, senza alcuna precauzione di sicurezza? Sarebbe così difficile per il Comune organizzare queste celebrazioni in una cornice controllata? Anche perché – particolare non trascurabile – nelle cataste date alle fiamme finisce materiale che sviluppa fumi nocivi (e qualcuno di sicuro dirà che con tutto l’inquinamento industriale che grava su Taranto non ha senso preoccuparsi di quattro falò: ragionamento cemmenefuttista anche questo, perché sono proprio il lassismo quotidiano generalizzato e la mancanza di una cultura della salute e dell’ambiente ad aver permesso agli inquinatori di fare impunemente i loro comodi per tanto tempo).
Ma il punto in fondo è un altro, ed emerge da una semplice constatazione: se il deprecabile episodio non fosse stato denunciato dai ragazzi di Obiettivo Borgo Antico, della sottrazione di materiali preziosi non si sarebbe accorto nessuno. I “tesori” si trovavano in uno dei tanti palazzi storici abbandonati, pericolanti e incustoditi dell’Isola. Quell’Isola che qualcuno con caparbietà cerca di far tornare a nuova vita, ma che è schiacciata in una morsa mortale dal disprezzo di molti suoi abitanti e dalla pochezza di chi per ruolo istituzionale dovrebbe prendersene cura. Nessuno era a conoscenza di quei “tesori” prima che venissero distrutti. Nessuno è riuscito a preservarli e a valorizzarli. Forse quel falò, come un’eutanasia, ha solo accelerato una fine comunque inevitabile.
Venditori di fumo: un estratto in anteprima sul Quotidiano di Puglia
 Clicca qui per leggere un estratto da Venditori di fumo, pubblicato in anteprima (il libro è in uscita il 12 novembre) dal Quotidiano di Puglia.
Clicca qui per leggere un estratto da Venditori di fumo, pubblicato in anteprima (il libro è in uscita il 12 novembre) dal Quotidiano di Puglia.
L’intervista a Federico Baccomo
 Per il Quotidiano di Puglia Giuliano ha intervistato Federico Baccomo Duchesne, in occasione dell’uscita di “Peep Show” (Marsilio), il suo terzo romanzo. Clicca qui per leggere l’intervista di Giuliano e la recensione di Teo Pepe.
Per il Quotidiano di Puglia Giuliano ha intervistato Federico Baccomo Duchesne, in occasione dell’uscita di “Peep Show” (Marsilio), il suo terzo romanzo. Clicca qui per leggere l’intervista di Giuliano e la recensione di Teo Pepe.
La città riscopre la bellezza dei suoi colori
 Articolo apparso sul Quotidiano di Taranto domenica 13 aprile.
Articolo apparso sul Quotidiano di Taranto domenica 13 aprile.
I totem pubblicitari che invitano a trascorrere la Pasqua in Puglia, nella grande galleria della Stazione Centrale di Milano fanno lo stesso effetto del monolito all’inizio di 2001 – Odissea nello spazio. I colori intensi e nitidi sulle foto che ricoprono le quattro facciate di ciascuna installazione sembrano fatti apposta per spiccare in quella particolare non-luce che è uno dei veri tratti distintivi del capoluogo lombardo. Una non-luce ulteriormente sottolineata dalla fioca illuminazione artificiale di quelle parti di stazione non toccate dai recenti lavori che l’hanno trasformata in un grande centro commerciale. Quelle parti in cui, fra marmi, soffitti altissimi e fregi, l’atmosfera è sospesa, come fuori dal tempo.
Del tutto contemporanea è invece la campagna della Regione Puglia, con tanto di hashtag che rimandano a Twitter e con colori brillanti che più brillanti non si può. Né il merito della sensazione visiva è solo della luce dei totem che retroillumina le immagini o di un sapiente lavoro di postproduzione fotografica. Quell’effetto è tutta farina del nostro sacco pugliese. Del resto il regista Giovanni Veronesi, che ha recentemente girato in Puglia un suo film, ha detto che mentre di solito bisogna intervenire col computer per rendere più intenso il colore del mare, per il mare pugliese ha avuto quasi l’esigenza di attenuarlo.
E’ azzurro, azzurrissimo, il mare del Canale Navigabile di Taranto, nella foto che ritrae il Castello Aragonese. Quando c’è la Pasqua di mezzo, Taranto assume nel sistema turistico pugliese il ruolo di primo piano che in altri periodi non ha. Anche se l’effettivo potere di attrazione dei Riti della Settimana Santa al netto del rientro in città dei fuori sede resta, almeno per chi scrive, un punto interrogativo.
“Ti racconto la città dei due mari” c’è scritto sulla foto. E poi, sotto: “Scopri Taranto e la sua affascinante storia millenaria”. Esiste un’altra grande stazione italiana in cui – e non da ora – è esposta una foto del Canale Navigabile. E’ quella di Firenze Santa Maria Novella, anch’essa, come quella di Milano, risalente al periodo fascista. Su un muro del grande spazio oltre la testa dei binari, una lunga striscia di foto vecchie quanto la stazione stessa, ritrae alcune delle principali città italiane. Taranto è sopra il tabellone delle partenze. Benché la foto sia in un algido bianco e nero, che ricorda nella sua staticità le immagini del vecchio Intervallo in tv, non si fa fatica a immaginare il messaggio che quell’immagine all’epoca voleva comunicare: progresso. L’obiettivo, più che sul Castello, è puntato sul Ponte, coerentemente con un’immagine di Taranto che fra Ventennio (Marina Militare) e Dopoguerra (Industria) è stata perlopiù “futurista”. La foto che in questi giorni campeggia a Milano, invece inquadra esclusivamente il Castello Aragonese.
Decida il lettore se prenderla come semplice suggestione giornalistica o invece come un più profondo spunto di riflessione, ma la frase che conclude questo articolo è la seguente: quasi un secolo fa una Taranto in bianco e nero inseguiva un sogno di modernità; oggi la città, postmoderna e disillusa, riscopre in technicolor le sue antiche origini.
P.S.: chi, folgorato dalle foto in Stazione, venisse preso dalla voglia di informarsi su come, da Milano, si può raggiungere Taranto con la ferrovia, scoprirebbe che, a parte un treno notturno che impiega dodici ore, non esistono collegamenti diretti fra le due città. E questo è senz’altro uno spunto di riflessione.
Emergenza occupazione: il commento
 Il commento, pubblicato sul Quotidiano di Taranto del 1° aprile, sulle vertenze lavorative e sulla disoccupazione a Taranto.
Il commento, pubblicato sul Quotidiano di Taranto del 1° aprile, sulle vertenze lavorative e sulla disoccupazione a Taranto.
Ora che la crisi è arrivata dappertutto, si dice che a reagire meglio siano le zone che in crisi erano già da un pezzo, perché dotate di “anticorpi”. Fosse davvero così, Taranto sarebbe in una botte di ferro. Ma in buona parte è solo una bugia pietosa. Le vacche grasse del passato, per chi le ha avute, servono ancora da riserva e da ammortizzatore. A chi invece aveva già toccato il fondo, ora non resta che scavare.
Taranto poi, come spesso succede, fa storia a sé. Industria di stato e Marina Militare: in una città di stipendiati, il dilagare di disoccupazione e precariato è qualcosa di particolarmente spiazzante. Le vertenze sindacali e i sit in, pur sacrosanti, sono battaglie di retroguardia, buone solo per cercare di limitare i danni in attesa che quel modo di lavorare, nel giro di poche generazioni, scompaia del tutto. Prima se ne prende atto, meglio sarà, e per fortuna anche da queste parti qualcuno sta iniziando ad accorgersene.
Certo non saranno le lettere a Renzi, o a chiunque altro in sua vece, a tirarci fuori dai guai. Quelle sono solo la dimostrazione di come ancora sopravviva una certa mentalità assistenzialistica che identifica il potere con le persone che lo gestiscono. La stessa mentalità che porta tanti disoccupati tarantini – pur meritevoli di solidarietà – a chiedere aiuto (o elemosina) al sindaco e non ai servizi per l’impiego, evidentemente sconosciuti o ritenuti inutili.
Ma forse quella bugia pietosa che vorrebbe le aree povere più attrezzate delle altre a fare fronte alla crisi ha un fondo di verità. Un milanese che si trovasse a vivere a Taranto, o in Puglia, resterebbe sorpreso dal rapporto che qui si ha coi soldi. Sconcertato da come, anche in situazioni prettamente lavorative, spesso si dimentichi (per nobiltà d’animo o per sciatteria) che lo scopo ultimo dell’attività è il guadagno. Ma anche affascinato, forse commosso, dal modo in cui chiunque – fosse anche uno che porta a casa duecento euro al mese o un disoccupato – se gli stai simpatico insista per offrirti un caffè, una pizza, una cena.
Il fatto è che, come ha detto il regista salentino Edoardo Winspeare in una recente intervista a Vanity Fair, “qui nessuno ha soldi ma nessuno parla di soldi”. Il suo film “In grazia di Dio” racconta di alcune donne che reagiscono alla congiuntura economica negativa reinventandosi contadine, e barattando il prodotto del loro lavoro con altri beni di prima necessità. La piccola grande lezione di questa storia non sta tanto nelle teorie della decrescita felice e nel ritorno alla terra, concetti che portati all’eccesso rischiano di diventare stucchevoli cliché pauperisti. La lezione sta piuttosto nella la forza di volontà delle persone, soprattutto di quelle più umili, l’abitudine a soffrire e a cambiare rapidamente i propri orizzonti. Soprattutto, il poter attingere, come estrema risorsa a quella che dovrebbe essere la prima, di risorsa: l’umanità e la capacità di aiutarsi a vicenda. Una risorsa, almeno questa, di cui al sud siamo – o eravamo? – molto ricchi.
L’intervista a Tommaso Pellizzari
 Un giornalista usa il denaro di una vincita al Superenalotto per fondare un movimento politico il cui scopo ultimo è l’estinzione del genere umano. È lo spunto iniziale di “Movimento per la Disperazione” (Baldini&Castoldi, 208 pagine, 14,90 euro), insolito e notevole romanzo di Tommaso Pellizzari. Clicca qui per leggere l’intervista sul Quotidiano di Puglia.
Un giornalista usa il denaro di una vincita al Superenalotto per fondare un movimento politico il cui scopo ultimo è l’estinzione del genere umano. È lo spunto iniziale di “Movimento per la Disperazione” (Baldini&Castoldi, 208 pagine, 14,90 euro), insolito e notevole romanzo di Tommaso Pellizzari. Clicca qui per leggere l’intervista sul Quotidiano di Puglia.
L’intervista a Sergio Caputo
 Il testo dell’intervista a Sergio Caputo, pubblicata sul Quotidiano di Puglia di lunedì 10 marzo.
Il testo dell’intervista a Sergio Caputo, pubblicata sul Quotidiano di Puglia di lunedì 10 marzo.
Album, libro, tournée. Sergio Caputo ha fatto le cose in grande per celebrare il trentennale (1983-2013) del suo album d’esordio, “Un sabato italiano”. Le canzoni del celebre disco sono state incise nuovamente, in versione più jazz, con l’aggiunta di due brani inediti, dando vita a un CD dal titolo “Un sabato italiano 30”. L’operazione revival si arricchisce poi di un libro, “Un sabato italiano memories” (Mondadori, prefazione di Carlo Massarini), in cui si racconta il “making of” delle canzoni e più in generale si rievocano le atmosfere e il periodo in cui sono nate. Infine, un tour teatrale sta attraversando l’Italia, con l’aggiunta in progress di nuove date e la promessa di un’appendice estiva.
Sergio Caputo, sono passati trent’anni da “Un sabato italiano”. Cosa è cambiato nel frattempo?
Il cambiamento più grande è stato quello tecnologico. Negli anni 80 c’erano già i primi computer ma nessuno pensava che potessero incidere così a fondo nelle nostre vite. Ma al di là di questo, trovo che l’Italia non sia molto cambiata da allora, né dal punto di vista del costume né da quello di una modernizzazione autentica e strutturale: siamo ancora fermi al pollaio politico giornaliero.
I primi 80 sono stati anni un po’ magmatici, di passaggio e trasformazione…
Musicalmente sono stati spesso criticati – soprattutto da chi è rimasto molto legato agli anni 70 – ma a sproposito, perché molto di ciò che ascoltiamo ora è nato proprio in quel periodo. Nel libro sono molto critico con gli anni 70 italiani, perché proprio mentre nel resto del mondo si godeva della musica migliore di sempre, qui ci si sparava e sprangava per le strade. E’ stato un vero furto generazionale. Anche musicalmente, il dogma dell’impegno esisteva solo da noi: nessuno ha mai detto a Neil Young che doveva cantare cose sociopolitiche. La musica come arte secondo me ha la missione di far stare bene la gente.
Cosa significa questo trentennale per “Un sabato italiano”?
Significa essersi resi conto che un album che avevo scritto trent’anni fa è diventato un classico: ha superato la barriera del tempo e toccato nuove generazioni. Da qui la necessità di inciderlo in un modo che possa farlo durare anche altri cinquant’anni. Anche perché né i testi né le musiche di quel disco sono legati a un periodo particolare, e solo gli arrangiamenti – con l’uso dei sintetizzatori applicato al jazz e allo swing – risentivano della moda dell’epoca e necessitavano di un aggiornamento.
Il remake è anche un modo di riappacificarsi con il Caputo classico, quello che nelle fasi successive della tua carriera sembravi volerti scrollare di dosso?
C’era un po’ di insofferenza per la gabbia in cui mi stavano rinchiudendo. Ma ho sempre inseguito il mio istinto, non ho mai fatto niente programmaticamente. A un certo punto ho sentito di voler andare in direzioni diverse e sono contento di averlo fatto, perché se avessi continuato a incidere sempre lo stesso album ora non sarei qui a fare concerti coi teatri pieni e i ragazzi che conoscono i miei testi a memoria.
Come si trova un musicista che ha sempre giocato con le parole nel ruolo di scrittore?
Molto bene. Mi piace il fatto di non essere vincolato, come nelle canzoni, dalla metrica, dalle rime e dalla durata. E poi, il ruolo di musicista impone relazioni sociali, tour, interviste… Invece i libri li puoi scrivere da solo, a casa tua, senza neanche vestirti, magari nella vasca da bagno. Scrivere libri per me è un grande piacere, e credo che sia una dimensione che porterò avanti.
Anche perché, se il mercato editoriale è in crisi, quello musicale lo è anche di più…
Soprattutto in Italia la musica sta vivendo un momento complicato, perché le danno sempre meno spazio. Negli Stati Uniti ci sono le stazioni radio dedicate a un genere musicale, qui invece può capitare di sentire in sequenza Bowie, la Zanicchi e – più raramente, perché non mi hanno mai passato molto – Caputo. Per promuovere in tv libro e album sono dovuto andare a “La prova del cuoco”, dove peraltro non ero fuori luogo perché sono uno chef, ma questo è un altro discorso.
Se Taranto è unica lo deve alla sua città vecchia
 Commento pubblicato sul Quotidiano di Puglia del 9 febbraio.
Commento pubblicato sul Quotidiano di Puglia del 9 febbraio.
Se si dice a un forestiero che Taranto è una città diversa da tutte le altre, si rischia di passare per campanilisti e provinciali. Ma a supporto di questa tesi, le argomentazioni sono parecchie. E la maggior parte di esse ha a che fare con la Città Vecchia.
Sono poche le città il cui centro storico è un’isola, e ancora meno (ammesso che ce ne siano altre), quelle in cui l’isola è adagiata fra due mari separati e comunicanti.
A Taranto, poi, il centro storico e il “centro” inteso come cuore commerciale e sociale non coincidono. Al contrario, sono separati anche fisicamente dall’acqua, e tenuti insieme solo da un ponte che si apre e si chiude, quasi a voler sottolineare quanto labile sia il legame fra le due sponde. L’isola che ha vissuto per secoli chiusa, fortificata, è cresciuta su se stessa, sviluppando una conformazione urbanistica e sociale del tutto particolare, completamente diversa dal circondario. Ma, cadute le servitù militari che vietavano di costruire fuori dall’isola, Taranto è fatalmente fuggita da se stessa e per molti versi non è più tornata.
E qui iniziano i problemi. Perché il fatto che la vita cittadina si sia spostata in buona parte altrove, ha sì preservato l’autenticità dell’Isola, ma ne ha anche determinato l’inesorabile abbandono. Anche il centro storico di Genova, per dirne una, ha versato a lungo in uno stato di degrado. Ma era lì, incastonato nel resto della città: non si poteva dimenticarlo o far finta che non esistesse. Così si è proceduto al suo progressivo recupero. Taranto vecchia, invece, no. Taranto vecchia langue ancora, benché negli ultimi anni diverse cose siano cambiate.
I due principali interventi di risanamento di Taranto vecchia (il Piano Blandino – più sostanziale – negli anni 70 e Urban – più “cosmetico” – ai tempi della Di Bello) hanno mostrato un limite in comune: prevedere una riqualificazione solo architettonica e non anche sociale (sebbene Urban, sulla carta, prevedesse anche quest’ultima). Oggi, in un certo senso, si sta verificando il problema contrario: al progressivo fiorire di attività (eventi, associazioni, centri culturali, caffè letterari, negozi, alberghi, ristoranti, il piccolo indotto dell’Università) fa da contraltare l’allarmante sgretolamento del patrimonio architettonico. Come se, ora che “dal basso” si saprebbe cosa fare e si ha voglia di farlo, “dall’alto” (leggi: istituzioni) non si sia più in grado o non si abbia la reale intenzione di preservare questo fondamentale bene comune.
Eppure è così chiaro, soprattutto in un momento storico in cui la città deve – che lo voglia o no – ripensarsi profondamente. E in cui si parla di “adozioni” e piani speciali di rilancio. Molto del destino di Taranto passa ancora dal suo passato, dalla sua culla millenaria: la Città vecchia. Chi non sa prendersi cura della propria storia, e della propria identità, difficilmente ha gli strumenti per costruire il suo futuro. Per questo, a ogni nuovo crollo nell’Isola, insieme a muri o edifici fatiscenti, sembra venire giù anche un pezzo di speranza.
“La gente che sta bene” (e “Il capitale umano”): il commento e le interviste
 Il commento di Giuliano sui film “La gente che sta bene” e “Il capitale umano”, e le interviste a Claudio Bisio, Francesco Patierno e Federico Baccomo, rispettivamente attore, regista e sceneggiatore di “La gente che sta bene”. Pubblicati sul Quotidiano di Puglia.
Il commento di Giuliano sui film “La gente che sta bene” e “Il capitale umano”, e le interviste a Claudio Bisio, Francesco Patierno e Federico Baccomo, rispettivamente attore, regista e sceneggiatore di “La gente che sta bene”. Pubblicati sul Quotidiano di Puglia.
Un uomo ricco e di successo frequenta un uomo molto ricco e molto di successo sperando di diventare come lui. Per inseguire il suo sogno di affermazione, trascura i veri valori della vita, compresi gli affetti: la partner che sul più bello si scopre incinta e la figlia in piena crisi adolescenziale. A un passo dalla meta qualcosa va storto e il “ricco aspirante ricchissimo” si vede cadere il mondo addosso. Un tragico incidente stradale spariglierà definitivamente le carte e – fra figli maschi oppressi dalle troppe aspettative, amanti che nascondono cicatrici sui polsi e personaggi seduti nella doccia immobili e cogli occhi sbarrati – le cose si risolvono, anche se non nel modo inizialmente immaginato.
Avete appena letto la trama non di uno ma di due film italiani attualmente in programmazione nelle sale: “Il capitale umano” di Paolo Virzì e “La gente che sta bene” di Francesco Patierno. Posto che nessuno ha copiato da nessuno (le due pellicole fra l’altro sono tratte da libri: “Il capitale umano”, liberamente, da “Human capital” di Stephen Amidon; “La gente che sta bene” dall’omonimo romanzo di Federico Baccomo), i punti in comune nella storia raccontata dai due film sono davvero tanti, sia nelle linee generali che nei dettagli, e non può essere una pura coincidenza. Prima possibile spiegazione: una certa autoreferenzialità e mancanza di fantasia del cinema italiano, simboleggiata per esempio dal fatto che unendo i due cast si ricompone pressoché al completo la famigerata (e simpaticissima, va detto) “Banda Salvatores”: da una parte Claudio Bisio, Diego Abatantuono e Claudio Bigagli; dall’altra Fabrizio Bentivoglio e Gigio Alberti. Una banda, si noti, anagraficamente più vecchia dei due registi. Seconda possibile spiegazione: a volte certi concetti galleggiano nell’aria e può capitare che due buoni film, efficaci nel raccontare lo spirito dei tempi, si concentrino sullo stesso tema. Che non è (solo) l’arroganza di certi ricchi che si fa beffe degli affanni dei comuni mortali, ma – più sottilmente – l’insensatezza di uno stile di vita basato esclusivamente sulle ambizioni materiali, ambizioni che peraltro oggi sono alla portata di sempre meno persone.
Se si somigliano nelle trame, i due film però differiscono molto tra loro sotto altri aspetti. Lo stile narrativo, per esempio. “La gente che sta bene” ha un’ispirazione televisiva (ma non suoni come una diminutio: i modelli sono le migliori serie tv americane, non certo alcune tristemente note fiction nostrane) che lo porta a concentrarsi sull’approfondimento dei personaggi e sulla creazione di un mood peculiare, fatto di umorismo acido e un tocco di surreale. “Il capitale umano” è invece più compiutamente cinematografico, prendendo dalla settima arte il respiro, i tempi, la varietà di stili, le tecniche narrative e anche qualche cliché. L’altra differenza sta nel finale: in uno (non diciamo quale) assistiamo a una redenzione un po’ buonista, sebbene parziale e per certi versi beffarda; nell’altro si fanno i conti con l’amara constatazione che c’è chi cade sempre in piedi e chi invece finisce per pagare, anche per colpe non sue.
“La gente che sta bene”, diretto da Francesco Patierno, con protagonista Claudio Bisio, affiancato da Diego Abatantuono, Margherita Buy e Jennipher Rodriguez, è basato sul secondo romanzo del trentacinquenne milanese Federico Baccomo, che racconta, alternando ironia e toni drammatici, di un manager di successo che viene improvvisamente licenziato in una Milano preda della crisi economica e finanziaria, e dei suoi tentativi sempre più spregiudicati di tornare in vetta.
“Il tema forte del film” spiega il regista Patierno, “è la responsabilità delle proprie azioni. Il protagonista Umberto Durloni inizialmente non si preoccupa del proprio operato, ma poi, quando ne tocca con mano le conseguenze, entra in crisi. Cerco di raccontare storie che siano soprattutto storie di personaggi, con dialoghi molto lunghi come accade in serie tv anglosassoni come ‘Madman’, “Dexter’ o ‘The office’. Il film è girato soprattutto in interni, ma nei pochi esterni Milano appare come una città che si sta costruendo, piena di gru, con uno skyline ancora non definito”.
“Di Milano mi piace raccontare l’aspetto della perdizione, che però è solo uno dei lati della città” sostiene Federico Baccomo, che del film è co-sceneggiatore. “Le vicende di ‘La gente che sta bene’ potrebbero svolgersi ovunque, per esempio negli Stati Uniti ma ci sono dei dettagli tipicamente italiani. Il sogno americano è farcela, arrivare; quello italiano è invece stare a galla, cavarsela. In fondo Umberto non vuole stare bene, ma vuole convincerti che lui sta bene, il che è molto italiano”.
“Mi viene in mente il film ‘Diario di una schizofrenica’” aggiunge Claudio Bisio, “in cui la protagonista continua a ripetere ‘Io sto bene, tu come stai?’ ma si vede che non sta bene affatto. Del libro di Federico ho apprezzato la comicità arguta e pungente, molto anglosassone, che mi ha ricordato quella di Walter Fontana. Quanto al lavoro sul set, è stato uno dei pochi film in cui ho rispettato la sceneggiatura così tanto. Io sono abituato a parafrasare la parte, per renderla più adatta a me, ma in questo caso non funzionava: le parole scritte nella sceneggiatura erano sempre le più giuste. Unica eccezione: le scene con Diego Abatantuono, con cui ci siamo presi delle libertà, forti di una consolidata intesa comica. C’è poi addirittura una scena ‘rubata’ tra la gente: quando arrivo a Berlino, scendo dal taxi e saluto tutti con un cordiale ‘scheisse!’, che in realtà vuol dire ‘merda’. Il tedesco che mi risponde insultandomi non è un attore ma un ignaro passante!”
“That’s (im)possible”: l’articolo in versione integrale
 Il 13 gennaio sul Quotidiano di Puglia è uscito un articolo (recensione e intervista all’autore) di Giuliano dedicato a “That’s (im)possible” (Caratterimobili), l’ultimo romanzo dello scrittore barese Cristò. Qui sotto, la versione originale dell’articolo, più lunga di quella pubblicata sul giornale.
Il 13 gennaio sul Quotidiano di Puglia è uscito un articolo (recensione e intervista all’autore) di Giuliano dedicato a “That’s (im)possible” (Caratterimobili), l’ultimo romanzo dello scrittore barese Cristò. Qui sotto, la versione originale dell’articolo, più lunga di quella pubblicata sul giornale.
Quando si ha a che fare con dei romanzi sotto forma di finto documentario (si chiamano mockumentary) o con altre simili formule narrative, la paura è quella di imbattersi in dei divertissement, magari raffinati e godibili, ma sostanzialmente fini a se stessi. Non è questo il caso di “That’s (im)possible” (Caratterimobili, 8 euro), terzo romanzo dello scrittore e musicista barese Cristò. In “That’s (im)possibile” alla forma si aggiunge la sostanza, cioè il contenuto. Di più: forma e contenuto si compenetrano, risultando reciprocamente funzionali e aumentando il valore del prodotto finale.
Partiamo dal contenuto: That’s (im)possible è una lotteria televisiva basata sull’estrazione di un numero da uno a infinito. L’assurdità dell’idea diventa paradossalmente il motivo del suo enorme successo. Non solo le probabilità di vincita sono pressoché nulle, ma è il gioco stesso a essere impossibile, non esistendo un sistema per selezionare uno fra infiniti numeri, garantendo a ciascuno di essi le medesime probabilità di uscita. Del resto le modalità di estrazione sono segrete, il che dovrebbe aumentare la diffidenza dei giocatori. Ma tutto ciò non sembra interessare ai milioni di persone che cercano di indovinare: la giocata costa poco, il montepremi è enorme e l’occasione è irripetibile, perché dopo la prima vincita la lotteria finirà per sempre.
Ora, la forma: all’espediente del documentario, con l’alternarsi di testimonianze orali delle persone coinvolte a vario titolo nella vicenda raccontata, Cristò aggiunge anche il classico stratagemma del ritrovamento del manoscritto: in una premessa e in una postfazione, un medico si presenta come il destinatario di un plico contenente la sceneggiatura del documentario. Nel gioco scoperto fra finzione e realtà, il medico sostiene che fatti e personaggi contenuti nel documento sono veri, salvo poi suggerire al lettore che lui stesso potrebbe essere un personaggio inventato allo scopo di rendere più credibile la vicenda.
“That’s (im)possible” non è una semplice riflessione sulla febbre da lotterie e giochi d’azzardo. La posta in gioco è molto più alta: è la ricerca della felicità. E’ il concetto di infinito, sospeso fra matematica e filosofia. Sono le grandi domande senza risposta dell’esistenza. “That’s (im)possible” ha anche una sua forza politica, che emerge graduale ma nitida man mano che il mosaico delle testimonianze svela il disegno completo dell’autore (e dell’ideatore della bizzarra lotteria). Funziona molto bene e crea suspense – ecco perché forma e contenuto sono complementari – il progressivo svelarsi della vicenda in tutti i suoi aspetti. Una vicenda di cui gli intervistati parlano al passato, ma che i lettori devono ricostruire pezzo dopo pezzo con impaziente curiosità.
Fra rimandi, citazioni, autocitazioni, falsa realtà e vera fantasia, l’ultimo scherzo è riservato ai primi cinquanta che compreranno il libro presso la Feltrinelli di via Melo a Bari: quel bollino rosso “1 €” che campeggia sulla copertina non è il prezzo del volume, ma il buono per una giocata al lotto da effettuare presso una vicina ricevitoria. La vincita non è garantita, l’arricchimento del pensiero sì.
Cristò (1976) è uno scrittore e musicista barese oltre che organizzatore di eventi culturali. Ha pubblicato i libri “Come pescare, cucinare e suonare la trota” (Florestano 2007), “L’orizzonte degli eventi” (Il Grillo 2011). È caporedattore del free-press Pool academy e collabora con i blog minimaetmoralia e Artribune. Il suo blog è: cantodiscanto.blogspot.com.
Come è nato questo romanzo?
L’idea di una lotteria basata sull’infinito mi è venuta all’improvviso parecchio tempo fa. In quel periodo mi capitava di giocare a “Win for life”, e riflettevo su come una vincita altamente improbabile potesse apparire a portata di mano: azzeccare otto o zero numeri su venti sembra molto più facile che indovinarne tre su novanta, ma in realtà è più difficile. L’idea mi sembrò subito bella, ma anche difficile da realizzare, per cui lasciai perdere.
E poi?
Tempo dopo mi venne a trovare lo scrittore di fantascienza barese Vittorio Catani, chiedendomi di partecipare con un racconto a un’antologia di fantaeconomia. Mi sembrò un segno del destino, anche se poi per questioni di tempi e di lunghezza del testo, l’opera è uscita come libro a sé. Mi rimisi al lavoro, lanciando su Facebook un appello a esperti di matematica competenti anche nella narrativa perché mi chiarissero le idee su alcune questioni, appello raccolto provvidenzialmente da Roberto Natalini, professore universitario e ricercatore del CNR. Ho poi fatto delle ricerche su Bruno de Finetti, uno dei padri della statistica e del calcolo delle probabilità. Un personaggio incredibile, un anticonformista che ha militato nel Partito Radicale e che fra l’altro fu arrestato per le sue opinioni sull’obiezione di coscienza. La figura di de Finetti mi ha ispirato il personaggio di Enrico Marinetti, l’eccentrico ideatore della lotteria.
Perché hai deciso di strutturare il romanzo come un finto documentario?
Mi sono ispirato a “Rabbia” di Chuck Palahniuk, che è fatto proprio in quel modo. Ho pensato che affidare certi argomenti a una voce narrante potesse appesantire troppo la narrazione. Il racconto corale in discorso diretto mi è sembrato più divertente da scrivere e da leggere.
A proposito di divertimento, il testo è pieno di citazioni…
Sì: c’è Vonnegut, c’è Antonio Moresco, c’è “Guida galattica per autostoppisti”… Anche i nomi dei personaggi non sono quasi mai casuali. Le citazioni, in effetti, si inseriscono per divertimento: è difficile che qualcuno le colga tutte, ma è probabile che ciascuno ne colga almeno una.
Perché il documentario è preceduto e seguito dalle note di un medico che dice di averlo ritrovato sotto forma di manoscritto?
Perché proponendo solo il documentario avevo l’impressione che la narrazione fosse troppo chiusa, e non mi piaceva che ogni pezzo andasse perfettamente al suo posto. Ho invece voluto introdurre un finale aperto, e qui entra in gioco un altro rimando, che i lettori per il momento non possono cogliere: la conclusione di “That’s (im)possible” coincide infatti con l’inizio di “La settima vita di Moebius”, un altro mio romanzo che però è ancora inedito.
Qualità della vita: i limiti della classifica
 Commento sulla classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, in cui Lecce si è classificata 90ma, Brindisi 92ma e Taranto 104ma. Pubblicato sul Quotidiano di Puglia del 3 dicembre.
Commento sulla classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, in cui Lecce si è classificata 90ma, Brindisi 92ma e Taranto 104ma. Pubblicato sul Quotidiano di Puglia del 3 dicembre.
Per comprendere i limiti della classifica del Sole 24 Ore (e, più in generale, di tutte le classifiche sulla qualità della vita), basterà un esempio. Fra le sei macrocategorie prese in considerazione, quella che abbassa fortemente la media voto di Brindisi, Lecce e Taranto è “Popolazione”. Particolarmente critica risulta la voce specifica “popolazione straniera residente regolare su 100 abitanti”. Vengono premiate le città con più stranieri, forse perché questi ultimi sono un indicatore di vivacità economica, forse perché denotano una predisposizione della città all’accoglienza, forse ancora perché si pensa che alto tasso di regolari significhi basso numero di clandestini. Nei tre capoluoghi della Puglia meridionale gli stranieri sono pochi. Dunque, Brindisi, Lecce e Taranto raccolgono punteggi infimi (da 1,56 a 2,10 punti). Bene, indovinate qual è la prima città italiana in questa categoria, che raccoglie ben mille punti? Prato. Sì, Prato, proprio il posto dove l’immigrazione cinese fuori controllo ha mandato all’aria un’economia e un tessuto sociale, proprio il luogo balzato in questi giorni alla ribalta della cronaca nera per il tragico rogo di schiavi in una delle tante fabbriche-dormitorio clandestine.
Lascia perplessi poi anche la composizione delle categorie: “Servizi & Ambiente”, per esempio, è formata da sei voci, di cui solo una è puramente “ambientale”: “Indice Legambiente”. Questo indice è a sua volta composto da ventisei indicatori di cui solo tre relativi alla qualità dell’aria. Risultato? Taranto si gode un lusinghiero 71mo posto (di gran lunga la prima città della Puglia) in “Indice Legambiente”, e un 78mo posto (molto al di sopra del suo piazzamento globale) in “Servizi & Ambiente”, guadagnando ben sedici posti rispetto all’anno scorso. I tarantini continuano a respirare idrocarburi policiclici aromatici in alte concentrazioni? Poco male: le “cause legali definite ogni cento sopravvenute o pendenti” sono ben 31,89. Vuoi mettere?
Insomma, meglio non dare troppo peso ai piazzamenti in valore assoluto, e concentrarsi invece su alcuni indicatori specifici, sulle variazioni rispetto all’anno scorso e sul confronto fra le città del nostro territorio. I progressi rispetto al 2012 di tutte le pugliesi possono essere motivo di moderata soddisfazione. Moderata perché il Sud continua a occupare mestamente le posizioni di coda e perché, anche rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno, la Puglia sembra non riuscire a farsi valere come pure dovrebbe (le tre città più grandi della regione nelle ultime undici posizioni, nessuna più in alto del 90mo posto).
Taranto abbandona la mortificante ultima posizione dell’anno scorso, e incamera un sorprendente venticinquesimo posto nella percentuale di diffusione della banda larga. La città dei due mari resta però in ritardo rispetto a Brindisi e Lecce. Il distacco si accumula soprattutto nella categoria “Tempo libero”, in cui Taranto è penalizzata in particolare nel numero di ristoranti e bar.
Quanto a Brindisi, spicca il diciottesimo posto nel rapporto fra sale cinematografiche e popolazione, ma sul fatto che una multisala contribuisca ad innalzare la qualità della vita di un centro urbano è lecito nutrire dei dubbi. Fra le tre città, Brindisi è quella che ha un punteggio più alto nella “Sportività”, ma può l’ottantanovesimo posto essere sufficiente per la città capolista nel basket di A1?
Analogamente, basterà a Lecce il pur ottimo trentasettesimo posto nella graduatoria del numero di librerie per meritare il titolo di Capitale europea dalla cultura 2019? Siena e Cagliari, due delle altre città in lizza, sono rispettivamente quarta e quinta; Perugia è sedicesima, mentre solo Ravenna (trentanovesima) e Matera (addirittura 103ma) fanno peggio del capoluogo salentino. A far propendere per l’ottimismo è la lusinghiera 28ma posizione di Lecce nella percentuale di startup innovative ogni diecimila giovani. E, soprattutto, la ragionevole speranza che queste classifiche vengano interpretate da chi di dovere con le dovute attenzioni e cautele.
Taranto prenda esempio da Cagliari
 Una riflessione sulla bocciatura della candidatura di Taranto a Capitale europea della Cultura. Pubblicato domenica 24 novembre sul Quotidiano di Puglia.
Una riflessione sulla bocciatura della candidatura di Taranto a Capitale europea della Cultura. Pubblicato domenica 24 novembre sul Quotidiano di Puglia.
Com’era prevedibile, Taranto non ha superato il primo turno di selezione del bando per la Capitale Europea della Cultura. Chi scrive aveva già espresso, dalle pagine di questo giornale, la sua opinione in merito: per come è stata presentata la candidatura, le possibilità erano praticamente nulle, ma il tentativo del Comune ha comunque avuto senso, a patto di intenderlo come una pura dichiarazione di intenti. Abbandonarsi oggi alle polemiche equivarrebbe a sparare sulla croce rossa. Molto più utile appare invece riflettere sugli esiti di questo primo round.
Scorrendo l’elenco delle sei finaliste, la prima cosa che salta all’occhio è la presenza di due città, Matera e Lecce, distanti meno di cento chilometri da Taranto. I motivi che hanno portato a escludere una candidatura congiunta con l’una o l’altra sono già stati ampiamente dibattuti. Ma al di là della vicinanza geografica, non è specchiandosi nelle sue vicine che Taranto deve guardare al suo fallimento. Matera e Lecce partivano da una posizione di vantaggio. Hanno infatti un’immagine già consolidata di città di cultura, dovuta nel primo caso all’inclusione nella lista Unesco dei siti patrimonio dell’umanità, e nel secondo a quella “brandizzazione” del territorio che – pur criticabile e criticata – ha sortito formidabili effetti mediatici, prima ancora che reali.
Piuttosto – dato che anche Siena, Ravenna e Perugia-Assisi sono realtà molto diverse da quella jonica – è a Cagliari che Taranto deve guardare. Cagliari è, come Taranto, una città marittima e portuale di dimensioni medio-grandi. Come Taranto è una città “non turistica” in una regione turistica. Come Taranto non è nota principalmente per essere una città di cultura, ma possiede in questo senso delle potenzialità inespresse. Cagliari dimostra che Taranto ce la poteva fare, dando torto a chi riteneva la città dei due mari incompatibile “per natura” con certi traguardi.
Ma perché allora Cagliari ce l’ha fatta e Taranto no? Confrontando i due fascicoli di candidatura, al di là di una maggiore precisione e modernità della proposta sarda, non si riscontrano distanze abissali nelle attività previste. A fare la differenza sono invece altri aspetti.
Primo: il sostegno da parte delle autorità locali. Cagliari gode dell’appoggio di tutti gli enti pubblici, compresa la Regione, delle sedi regionali dei ministeri, di Università, Diocesi, Autorità Portuale, Camera di Commercio, associazioni di categoria, sindacati, Film Commission, fondazioni e molto altro. Taranto risponde con due delibere del Comune (e ci mancherebbe!) e un protocollo d’intesa coi comuni della provincia.
Secondo: la partecipazione degli artisti, degli operatori del mondo socio-culturale e degli abitanti, una delle condizioni richieste dal bando. Cagliari dichiara che nel 2013 sono stati organizzati incontri con associazioni culturali del territorio, operatori turistici, della ricettività, della ristorazione e del trasporto, associazioni ambientaliste, Università, ecc.. Non risulta che a Taranto sia stato fatto niente di simile, a dimostrazione di quella diffidenza reciproca (spesso ben motivata, va detto…) che da queste parti separa in compartimenti stagni istituzioni e società civile. E’ imperdonabile fra l’altro che – in una candidatura tutta sbilanciata sui progetti futuri e sul cosa la città si aspettava, anziché sul cosa aveva da offrire – si siano trascurate quasi del tutto le iniziative più interessanti della Taranto di oggi, da “L’Isola che vogliamo” al recupero dei vecchi saperi marinari, fino alle crociere di osservazione dei delfini, cui pure lo slogan del progetto faceva riferimento.
Infine, il budget. Taranto non può vantare accordi già conclusi con sponsor privati e, nel dichiarare le risorse riservate alla cultura negli ultimi cinque bilanci mette sul piatto percentuali imbarazzanti (numeri decimali, contro quelli a due cifre del Comune di Cagliari). La mancanza di risorse finanziarie e lo scetticismo del mondo imprenditoriale vengono correttamente segnalati come punti deboli del progetto. Ma non sono mancanze di poco conto, quando si concorre a un finanziamento del genere, la cui logica è proprio quella di erogare denaro per mobilitare risorse aggiuntive.
Si potrà obiettare che tutte queste mancanze derivano dall’aver lavorato con poco tempo e pochissime risorse a disposizione, insomma in emergenza. Obiezione che può essere accolta solo in parte: i limiti vanno ricercati anche nell’approccio adottato. Ma in fondo il punto è proprio questo: perché bisogna lavorare sempre in emergenza? Riflettiamoci, prima di sprecare altre opportunità.
Cosa penso di Masterpiece
 Articolo pubblicato sul Quotidiano di Puglia del 24 novembre.
Articolo pubblicato sul Quotidiano di Puglia del 24 novembre.
“L’Italia è un paese di scrittori”. A Masterpiece – l’X-Factor dei libri trasmesso da Raitre (seconda puntata stasera alle 22,50) – è bastata una frase per spiegare l’idea forte su cui si basa il programma. Il format, però, nasconde un problema: il talento letterario è meno televisivo di quello musicale. Se per misurare la stoffa di un cantante basta sentirlo eseguire dei brani, per comprendere la qualità di un romanzo non è sufficiente ascoltarne frettolosamente dei brevi estratti – il massimo che si possa fare in tv.
E’ anche (ma forse non solo) per questo che a Masterpiece l’accento, più che sulla scrittura sembra posto sugli scrittori. Gli scrittori, in uno show televisivo (ma forse non solo lì), devono essere innanzitutto dei personaggi. E, secondo un cliché sempre in voga, il personaggio-scrittore deve essere uno che ha dei problemi. “Cosa fai nella vita?” chiedono infatti i giudici di Masterpiece al primo concorrente. E lui: “soffro”. Tutti gli scrittori in gara hanno biografie adeguate a questa dichiarazione programmatica, fra ricoveri in ospedali psichiatrici, soggiorni nelle patrie galere, lavori massacranti in fabbrica, anoressia, tentati suicidi, rapporti difficili con l’altro sesso e coi genitori, questi ultimi quasi tutti morti. Come se il disagio esistenziale fosse condizione necessaria, o addirittura sufficiente, per essere scrittori di successo. Una regola smentita in primo luogo proprio dai tre giudici, tutti socialmente ben inseriti e all’apparenza “risolti”.
Messa in questi termini, con gli scrittori-personaggi e le loro storie private in primo piano, ecco che anche il mondo dei libri diventa telegenico. Del resto Masterpiece non è altro che un inchino dell’editoria alla tv: portando la selezione del libro da pubblicare in 100mila copie davanti alle telecamere, la Bompiani più che verificarne la qualità ne ipoteca in anticipo il successo.
Lo show è comunque piacevole e, pur nei limiti dettati dalle esigenze di spettacolarità (vedi le umiliazioni gratuite ai concorrenti eliminati), offre agli aspiranti scrittori qualche dritta interessante su come funziona il mondo editoriale. E ciò non solo per i consigli e le osservazioni dei tre giudici (Giancarlo De Cataldo – di gran lunga il più simpatico – Taiye Selasi e Andrea De Carlo) e del coach Massimo Coppola, ma anche per le prove che gli scrittori sono chiamati a superare nella seconda parte del programma. Il doversi misurare con un racconto su un argomento imposto e in un tempo limitato può apparire mortificante, ma avvicina alla scrittura “su commissione” che è parte dell’orizzonte di chi scrive per mestiere, mentre l’“elevator pitch”, cioè il tentativo di convincere una persona influente della bontà del proprio lavoro avendo a disposizione un solo minuto, è esperienza comune a molti autori alle prime armi.
In definitiva, la morale è che per sfondare coi libri non ci vuole solo il talento, ma bisogna anche essere versatili, comunicativi e saper “bucare lo schermo”. A Masterpiece tutto ciò è portato all’eccesso, ma nel mondo reale le cose non sono troppo diverse. E non è detto che sia solo un male.
