 Venerdì 11 maggio alle 15,30 presso lo Spazio Stock (padiglione 5) si terrà una presentazione di Lutto Libero. Giuliano vi prenderà parte insieme a diversi altri autori dell’antologia e ad Alessio Giannone, alias Pinuccio.
Venerdì 11 maggio alle 15,30 presso lo Spazio Stock (padiglione 5) si terrà una presentazione di Lutto Libero. Giuliano vi prenderà parte insieme a diversi altri autori dell’antologia e ad Alessio Giannone, alias Pinuccio.
L’intervista su Mangialibri
 Clicca qui per leggere l’intervista a Giuliano sul suo tifo, apparsa su Mangialibri il 20 aprile a firma di Raffaello Ferrante.
Clicca qui per leggere l’intervista a Giuliano sul suo tifo, apparsa su Mangialibri il 20 aprile a firma di Raffaello Ferrante.
Lutto libero
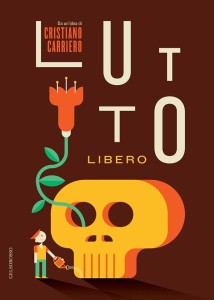 “Perché l’unico modo che abbiamo per rispondere alla morte è la vita”
“Perché l’unico modo che abbiamo per rispondere alla morte è la vita”
Esce per l’editore Gelsorosso un’antologia il cui ricavato verrà devoluto all’Ant. Giuliano partecipa con un racconto intitolato “La Dea”.
Da un’idea di Cristiano Carriero
Storie di:
Ezio Azzollini, Donato Barile, Matteo Bianconi, Matteo Caccia, Ilaria Calamandrei, Cristiano Carriero, Giusy Cascio, Michele Dalai, Tommy Dibari, Fabio Fanelli, Virginia Gaspardo, Marco Maddaloni, Marco Napoletano, Giulia Olivi, Fulvio Paglialunga, Giuliano Pavone, Claudio Pellecchia, Lucia Perrucci, Alessandro Piemontese, Francesco Poroli, Ferdinando Sallustio, Ivan Tabanelli, Roberto Venturini.
Prefazione del sociologo Andrea Fontana.
Illustrazione in copertina di Francesco Poroli.
Si può ricordare l’estate di un lutto come la più bella di sempre?
Si può tornare a sorridere dopo aver perso ciò che avevamo di più caro?
Ventitré autori rispondono, cercando nuovi occhi per guardare la morte, senza nascondere le ferite, scegliendo non di dimenticarla, ma di accettarla e, semmai, assecondarla.
Questo libro nasce da un’immagine: un tatuaggio sul braccio sinistro di Cristiano Carriero, l’ideatore dell’antologia. Al centro del tatuaggio, c’è un teschio messicano. Intorno, tanti fiori colorati che rappresentano la vita, la rinascita.
Ci sono tanti modi per raccontare la morte, che sia essa la perdita di una persona cara o la fine di un amore. In Lutto libero c’è la volontà di rispondere alla morte con l’ironia di chi non vuole scendere a compromessi per liberarsi in modo catartico di un momento durissimo, ma senza dimenticarlo. E soprattutto con il desiderio di tornare a sorridere, di abbracciare un amico, di fare l’amore perché «l’unico modo che abbiamo per rispondere alla morte è la vita».
Ventitré autori esorcizzano il loro lutto più grande in una raccolta di racconti piena di vitalità. Le storie sono firmate da scrittori come Michele Dalai, Matteo Caccia, Roberto Venturini, Giuliano Pavone, Tommy Dibari, Cristiano Carriero, da giornalisti come Fulvio Paglialunga (Raiuno) e Giusy Cascio (Tv Sorrisi e Canzoni), da blogger e influencer come Matteo Bianconi, Donato Barile, Alessandro Piemontese, accanto al pluripremiato vincitore di telequiz Ferdinando Sallustio e tanti altri.
Tutti insieme, per un grande obiettivo: aiutare Ant – Assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore e alle famiglie con il ricavato delle vendite del libro.
Il 10 febbraio a Carpi nel segno di Erasmo
 Sabato 10 febbraio a Carpi si terrà un grande evento in memoria di Erasmo Iacovone, la leggenda del calcio tarantino scomparsa tragicamente 40 anni fa. Giuliano coordinerà gli interventi.
Sabato 10 febbraio a Carpi si terrà un grande evento in memoria di Erasmo Iacovone, la leggenda del calcio tarantino scomparsa tragicamente 40 anni fa. Giuliano coordinerà gli interventi.
Iacovone è il nome di una storia che non comincia col c’era una volta. Erasmo c’è. E ci sarà. Una volta ancora. Dopo i ricordi, oltre le commemorazioni. Il racconto di Iaco si rinnova, come materia che si auto-genera. Dai ritagli stropicciati di un giornale ai frame d’immagini ri-colorate di YouTube: la narrazione dell’Erasmo popolare unisce i tempi e 40 anni, d’un tratto, s’azzerano. Tanti ne sono trascorsi dal 6 febbraio del ’78, giorno della sua tragica scomparsa. Per l’occasione, l’associazione “Fondazione Taras 706 a.C.”, supporters’ trust del Taranto Football Club 1927, ha organizzato una tappa speciale del “Taranto Day on Tour”, l’appuntamento che riunisce i tifosi rossoblù sparsi in giro per l’Italia.
“Nel segno di Erasmo” è il nome dell’evento straordinario, che si terrà sabato 10 febbraio 2018 a Carpi, in Sala Duomo, a partire dalle ore 17. Nel centro carpigiano, Iacovone ha vissuto anni preziosi per la sua vita privata e professionale, prima dell’exploit di Mantova e della consacrazione nella città dei Due Mari. Lì, i tifosi del trust tarantino, insieme con la signora Paola e con Rosy, rispettivamente vedova e orfana dell’indimenticato bomber di Capracotta, hanno scelto di riannodare i lembi di una storia che interpella i ricordi personali, i sogni calcistici e le speranze di generazioni di tifosi ionici, mantovani e carpigiani. Lì, gli occhi che hanno visto Erasmo, le orecchie che lo hanno ascoltato si ritroveranno in un emozionante pomeriggio condotto dallo scrittore tarantino Giuliano Pavone, autore, tra gli altri, de “L’eroe dei due mari” (2010, Marsilio).
Nel corso dell’evento sarà proiettato il cortometraggio “Iaco”, scritto e diretto da Alessandro Zizzo e prodotto da Apulia Film Commission e Kimera Film, che, pubblicato su Repubblica.it nel 2016, ha emozionato migliaia di tifosi. Presenzierà alla proiezione l’attore Angelo Argentina, che nel film ha vestito i panni di Erasmo. Un prezioso archivio fotografico degli anni emiliani di Iacovone sarà reso pubblico. Inoltre, ricordi e testimonianze sull’uomo e sul campione saranno portati da amici ed ex compagni di squadra, tra cui il mantovano Franco Panizza, che con Iaco ha condiviso, anche da compagno di stanza, l’ultima stagione tarantina, e il fisioterapista Bruno Brindani, che fu lo “sponsor” per l’arrivo dell’attaccante in terra ionica. L’attore tarantino Massimo Cimaglia – che nel cortometraggio interpreta Giovanni Fico, presidente del Taranto in quegli anni – leggerà infine una raccolta di brani scritti dai tifosi rossoblù per il contest “Il mio Iaco”, lanciato dalla Fondazione Taras alcune settimane fa.
L’organizzazione dell’iniziativa, affidata a un gruppo di tifosi tarantini fuori sede, il patrocinio concesso dal Comune di Carpi e dal CONI Emilia-Romagna e la partecipazione di ospiti, amici e tifosi provenienti da tutta Italia, testimoniano l’appartenenza trasversale del mito di Erasmo Iacovone. L’appuntamento è per sabato, a Carpi. Nel segno di Erasmo, ovviamente. Sul suo “9” non è mai calato il sipario.
Iacovone, la piccola Superga rossoblù
 Quarant’anni fa moriva Erasmo Iacovone. Clicca qui per leggere l’articolo scritto da Giuliano in una doppia pagina che il Quotidiano di Puglia ha dedicato alla leggenda del calcio tarantino.
Quarant’anni fa moriva Erasmo Iacovone. Clicca qui per leggere l’articolo scritto da Giuliano in una doppia pagina che il Quotidiano di Puglia ha dedicato alla leggenda del calcio tarantino.
La guerra dei murazzi di Enrico Remmert
 Clicca qui per leggere l’articolo, uscito sul Quotidiano di Puglia del 20 dicembre, su La guerra dei murazzi, l’ultimo libro di Enrico Remmert.
Clicca qui per leggere l’articolo, uscito sul Quotidiano di Puglia del 20 dicembre, su La guerra dei murazzi, l’ultimo libro di Enrico Remmert.
Dimenticare, di Peppe Fiore
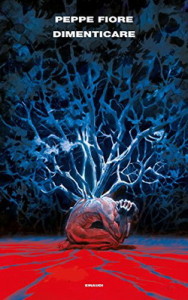 Clicca qui per leggere la recensione di “Dimenticare”, l’ultimo romanzo di Peppe Fiore, apparsa sul Quotidiano di Puglia del 12 dicembre.
Clicca qui per leggere la recensione di “Dimenticare”, l’ultimo romanzo di Peppe Fiore, apparsa sul Quotidiano di Puglia del 12 dicembre.
L’impero del sogno, Vanni Santoni
 La recensione di “L’impero del sogno” di Vanni Santoni, apparsa sul sito The Review Magazine
La recensione di “L’impero del sogno” di Vanni Santoni, apparsa sul sito The Review Magazine
“Don’t judge a book by its cover” cantava Frank-N-Furter, lo “sweet transvestite” del Rocky Horror (Picture) Show. Eppure lo facciamo tutti, specialmente quando la cover in questione non passa inosservata. È il caso di quella di “L’impero del sogno”, ultimo romanzo di Vanni Santoni, realizzata da Vincenzo Bizzarri, che può essere definita in vari modi ma di certo non sobria. In un paesaggio crepuscolare appaiono, in disordine sparso, elefanti dalle zampe slanciate alla Dalí, una ziggurat, un drago alato, Castel del Monte, un leone, un labirinto di siepi, alcuni personaggi del Mago di Oz, un insetto gigante e ancora molto altro. Il tutto in un affollamento ridondante e con un senso delle proporzioni e delle prospettive che ricorda le opere di Bosch ma anche alcune rappresentazioni sacre indiane. Al centro, sospeso, un uovo trasparente al cui interno, in un liquido amniotico dorato con stelline e pianeti galleggianti, è accucciata una bambina.
Ora, soprattutto se – come chi scrive – non si è appassionati di narrativa Fantasy, la tentazione di lasciare il tomo sulla pila insieme agli altri in attesa che (forse) arrivi il suo momento, è forte. Perché, viene da pensare, “L’impero del sogno” o è un brutto Fantasy oppure… Ed è proprio la promessa sospesa di quell’“oppure”, insieme al consiglio del vecchio Frank-N-Furter e soprattutto all’ottimo ricordo dei lavori precedenti di Santoni – uno scrittore capace di coinvolgerti anche in temi che non senti tuoi – a spingere ad aprire il libro per concedere una guardinga occhiata alle prime righe. Venendone immediatamente risucchiati e riuscendo a staccarsi dalla storia solo un paio di giorni dopo, a lettura conclusa.
Il fatto è che “L’impero del sogno” non è un Fantasy, o forse non è il classico Fantasy, e sicuramente non è solo un Fantasy. Insomma, è un’opera che sfugge ai tentativi di classificazione perché con i generi narrativi, ma anche con i livelli narrativi, ma anche con le forme di narrazione (che non sono certo solo i libri) gioca continuamente. Così è un gioco, sebbene non del tutto fine a se stesso, quello con cui Santoni accumula tonnellate di citazioni, ed è con fare giocoso che omaggia gli immaginari fantastici portandoli spesso a livello di caricatura. A suo modo però “L’impero del sogno” è anche un romanzo di formazione e una storia che ci dice qualcosa sui tempi e sui luoghi – quelli reali – in cui è ambientata.
Federico Melani, detto il Mella, ventenne sfaccendato perso nella provincia toscana degli anni 90, inizia a fare un sogno molto vivido e “seriale”: la vicenda è sempre la stessa, e procede di sonno in sonno. Ma i fatti vanno avanti, in sua assenza, anche quando Federico è sveglio, per cui il ragazzo – che nel mondo reale ha pochi motivi di soddisfazione – si ritrova a indursi il sonno in vari modi pur di non perdere terreno e di portare a termine la sua missione. Missione che consiste nel prendersi cura di una bambina-dea, permettendole di creare il suo mondo e difendendola da schiere di nemici che hanno le sembianze di draghi, extraterrestri, robot, divinità antiche e altri personaggi fantastici. Presto il sogno sconfina nella veglia e Federico, in una sorta di “effetto Droste”, si ritrova confuso fra veglia e sogno e/o fra più livelli di sogno.
La “guerra” avviene con logiche da videogioco o da gioco di ruolo, con i nemici che si approssimano uno alla volta, in sequenza, e il protagonista che sceglie per ciascuno le armi più adatte, dall’alabarda all’elicottero lanciamissili del futuro. I nemici assumono forme che rispecchiano gli incubi infantili, le fantasie e l’immaginario del Mella, che poi è l’immaginario dell’autore, che poi è – anche a essere meno impallinati e colti di Santoni – più o meno l’immaginario di chiunque sia nato fra i 70 e i primi 80. Un immaginario fatto indifferentemente da libri, film, telefilm, cartoni, fumetti, giochi e videogiochi, in cui non importa se si ritrovano mischiati la cultura alta e quella pop, anzi, al contrario, importa mischiarle il più possibile fino a renderle quasi inscindibili.
Ecco che il disordine della copertina – una copertina anche bella a suo modo, per carità, però insomma… – assume un significato ben preciso, un valore quasi programmatico di fronte a questa “Santoneide” in cui l’autore, con tono da cazzeggio raffinato, ci invita a godere della frenetica narrazione senza preoccuparci di cosa è reale o immaginario, autobiografico o generazionale, narrativo o metanarrativo. E in cui, al culmine del crossover, personaggi e fatti si mischiano (o sono coerenti) con quelli narrati nei suoi precedenti lavori, contribuendo così alla loro “continuity”.
Borg McEnroe, il film
 Quando ero piccolo, mamma e papà comprarono per la mia cameretta due poster di campioni. In uno c’era un Mennea-fasciodinervi appena scattato dai blocchi di partenza. E fin qui, niente da ridire, anzi, chapeau. Nell’altro c’era Bjorn Borg. E qui qualche problema c’era. Perché Borg era un grande, d’accordo, ma nel dualismo quasi idealtipico con McEnroe io stavo (come quasi chiunque conoscessi, per la verità) con l’isterico newyorkese, non certo con l’algido svedese (e per dirla tutta quello che mi stava più simpatico in assoluto era Jimmy Connors).
Quando ero piccolo, mamma e papà comprarono per la mia cameretta due poster di campioni. In uno c’era un Mennea-fasciodinervi appena scattato dai blocchi di partenza. E fin qui, niente da ridire, anzi, chapeau. Nell’altro c’era Bjorn Borg. E qui qualche problema c’era. Perché Borg era un grande, d’accordo, ma nel dualismo quasi idealtipico con McEnroe io stavo (come quasi chiunque conoscessi, per la verità) con l’isterico newyorkese, non certo con l’algido svedese (e per dirla tutta quello che mi stava più simpatico in assoluto era Jimmy Connors).
Ma pazienza: il poster restò al suo posto, e direi senza conseguenze rilevanti sul mio profilo psichiatrico.
Ora arriva questo film bellissimo (al netto di qualche eccesso di lirismo in alcune scene finali), chiamato semplicemente “Borg McEnroe” e vengo a scoprire che, in particolare nella loro infanzia, McEnroe era un pochino meno McEnroe, ma soprattutto che Borg era molto meno Borg. E cioè che l’incazzoso e ribelle americano da piccolo era una specie di genietto dei numeri e che era spinto dai genitori verso l’eccellenza scolastica, mentre il giovane Bjorn era molto più irascibile di un McEnroe in overdose da caffè, tanto da venire sospeso per indisciplina dal circolo tennis della sua città natale. La sua proverbiale imperturbabilità non era calma, ma capacità, maturata nel tempo, di convogliare rabbia, ansia, stress e paura esclusivamente nel gioco. Borg era una pentola a pressione pronta ad esplodere, come in parte forse hanno dimostrato il precoce ritiro e le movimentate vicende extrasportive.
“Borg McEnroe” è una produzione scandinava, ed è principalmente per questo che si concentra soprattutto su Borg (McEnroe a volte è davvero troppo macchiettistico. Anche più del vero McEnroe, intendo). Ma questa scelta “patriottica” permette di approfondire quella che fra le due sembra la personalità più complessa, sicuramente la più sofferta. E mi fa pensare che quello appeso nella mia cameretta da bambino, forse, non era il poster sbagliato.
L’eroe dei due mari compie 7 anni
 Il 29 settembre 2010 veniva pubblicato L’eroe dei due mari, il primo, fortunato romanzo di Giuliano. Clicca qui per vedere la pagina con la sinossi e il booktrailer.
Il 29 settembre 2010 veniva pubblicato L’eroe dei due mari, il primo, fortunato romanzo di Giuliano. Clicca qui per vedere la pagina con la sinossi e il booktrailer.
Né padri né figli di Osvaldo Capraro
 Clicca qui per leggere la recensione, pubblicata sul Quotidiano di Puglia dello scorso 18 settembre, di “Né padri né figli”, il noir di Osvaldo Capraro ripubblicato da Terrarossa.
Clicca qui per leggere la recensione, pubblicata sul Quotidiano di Puglia dello scorso 18 settembre, di “Né padri né figli”, il noir di Osvaldo Capraro ripubblicato da Terrarossa.
Il podcast di Plot Machine
Lunedì 17 a Radio1 con Inchiostro di Puglia
Brasiliani d’Italia
 Articolo pubblicato nel 2013 su Football Magazine.
Articolo pubblicato nel 2013 su Football Magazine.
L’ultimo dei brasiliani d’Italia, il più vero, è stato Bruno Conti. Titolo guadagnato sul campo, il suo. Un campo torrido e dal prato verde brillante: quello dello stadio Sarriá di Barcellona, in cui un pomeriggio dell’estate 1982 i brasiliani – quelli autentici – furono sconfitti dagli italiani. E niente fu più come prima.
Di quel titolo l’ala giallorossa fu investita ufficialmente proprio da un brasiliano. E non da uno qualsiasi. «È Bruno Conti il vero brasiliano dei mondiali; è il più forte fra tutti i giocatori che ho visto in Spagna. Credevo che giocatori come lui non ne nascessero più». Così parlò Pelé.
Conti, però, un po’ brasiliano si sentiva già da prima: lui, al fútbol bailado, si era sempre ispirato. E anche a chi si beava nel vederlo giocare – dribbling irresistibile, tiro esplosivo – l’accostamento veniva spontaneo. Hai un tocco sopraffino? Sei portato alla giocata spettacolare? Col pallone hai una confidenza finanche eccessiva, al limite dell’autocompiacimento? Allora sei un brasiliano. Un’equivalenza, questa, a metà fra complesso di inferiorità e orgoglio della diversità.
Perciò quando se lo trovò davanti, il Brasile – forse il miglior Brasile di sempre, almeno per nove undicesimi – Bruno dovette sentirsi un po’ confuso. Un soldato blu, anzi azzurro, diviso fra appartenenza e vocazione. Perché se per caso avesse vinto, avrebbe finito per sconfiggere anche una parte di se stesso. Prima della partita azzardò mentalmente un pronostico, o forse un salomonico auspicio, riportato nel libro “Il mio Mundial”: «“Finisce due a due” mi dicevo “noi salviamo la faccia, ma loro vanno in finale. Forse è giusto così”». Forse. Ma qualcuno aveva scritto un epilogo diverso, fatto di braccia alzate nel cielo di Madrid e bagni nelle fontane di tutta Italia.
Conti è più brasiliano dei brasiliani. Non si tratta solo di dare del tu al pallone, è proprio una questione di impostazione. Prendiamo il primo gol di Rossi, quel pomeriggio. Tutti ricordano il cross di Cabrini da sinistra e Pablito che irrompe a valanga sul secondo palo. Ma se mandiamo indietro di qualche secondo il vhs d’annata, vediamo che l’azione inizia da destra, da Bruno Conti. A centrocampo fa una doppia giravolta su se stesso, accarezzando la palla col tacco, e avanza di alcuni metri. Poi rientra, e con l’esterno sinistro taglia il campo orizzontalmente con un passaggio a uscire che finisce docilmente fra i piedi del Bell’Antonio. Ecco, non è questione di morbidezza e precisione del passaggio: è proprio che in Italia un gesto del genere non si fa, non si è mai visto.
Conti è il brasiliano d’Italia. Ma quella partita la vince perché è brasiliano fra gli italiani. Fossero scesi in campo un portiere e dieci Bruno Conti, quell’incontro non l’avremmo vinto. Conti era lì per confermare, con la sua eccezionalità, la regola italiana. Sembrava dire ai suoi avversari/compagni sudamericani “vedete? Siamo capaci anche noi” (fine del complesso di inferiorità). “Ma siamo capaci anche d’altro” aggiungeva il resto della squadra, rimarcando così l’orgoglio della diversità. E il trionfo epocale arrivò, oltre che per il sinistro velluto e dinamite di Conti, anche per l’istinto omicida di Rossi, la lucida essenzialità di Antognoni, il furore strappamaglie di Gentile, l’atavica saggezza di Scirea, l’algida concentrazione di Zoff e la sana avvedutezza di papà Bearzot.
Eppure Conti non ha l’aspetto del brasiliano. Soprattutto, non somiglia a quei brasiliani. Atletici, statuari, perfetti, armonicamente multirazziali. Quasi divinità classiche. Lui – guizzante Calimero senza collo – della divinità classica ha solo il nome del paese in cui è nato: Nettuno. Dall’altra parte c’è chi invece si chiama come un filosofo greco – Socrates – e del filosofo ha anche il sussiego, lo sguardo e la barba. Sguardo e barba: se Socrates li ha da filosofo, quelli di Junior sono da dissidente politico, o da cantautore impegnato. In casa nostra invece, barbe poche, finiti gli anni 70, e quanto ai baffi, quelli provvisori di Bergomi e quelli estemporanei di Gentile sembrano più che altro baffi da carabinieri. Anche gli sguardi da carabinieri hanno quei due, e l’attitudine alla custodia punitiva, da esercitare in coppia.
Ma seduto in panchina, sulla panchina dell’Italia, quel giorno c’è un uomo che ha i baffi da brasiliano. E non solo quelli: pure lo sguardo, intenso e insieme vago. Un Rivelino de noantri. Per non parlare dei piedi. È Franco Causio. Ed è l’unico, insieme a Conti, che può legittimamente fregiarsi del titolo di brasiliano d’Italia. E infatti oltre a “il Barone” (il Barone e Conti: noblesse oblige…) era soprannominato anche “Brasil”.
Causio di Conti era stato il predecessore in Nazionale. Il suo apporto più significativo alla spedizione spagnola fu un bluff che giocò a Pertini nella partita a scopone scientifico in aereo, sulla via del ritorno. In campo, a parte la passerella premio che Bearzot gli concesse all’ultimo minuto di Italia-Germania, giocò solo per un tempo contro il Perù, nella partita che – coincidenza singolare – vide Bruno Conti siglare il suo unico gol della manifestazione.
Il mondiale di Causio era stato senza dubbio Argentina ’78. Causio insomma, sta a Bruno Conti come il mondiale sudamericano sta a quello iberico. E questo spiega la differenza fra i due. Se Argentina ’78 fu una meravigliosa incompiuta, Spagna ’82 sancì il trionfo. Forse in Argentina giocammo addirittura meglio, molto probabilmente senza quella tappa di avvicinamento non avremmo tagliato il traguardo per primi quattro anni dopo, ma la storia si è fatta a Madrid. Stesso discorso per i due calciatori brazilian style: Causio fu grandissimo, Conti definitivo. Anche perché Conti il Brasile lo batté. Causio, invece, contro il Brasile segnò (un gol di testa alla Paolo Rossi), colse anche una traversa, ma poi la sua Italia crollò sotto i colpi da fromboliere di Nelinho e della buonanima di Dirceu. E poi quella era solo la finale per il terzo posto, non la rampa di lancio verso il tetto del mondo.
Certo, se si parla di club, il più vincente dei due è senz’altro Causio, che con la Juve di Trapattoni fece incetta di scudetti (sei), vincendo anche una Coppa Uefa. Conti, nella Roma, di scudetto ne avrebbe vinto solo uno, proprio l’anno successivo al Mundial, compagno di squadra di quel Falcão a cui al Sarriá aveva strozzato in gola l’urlo del momentaneo 2-2 (nel campionato successivo Causio invece avrebbe accolto Zico nell’Udinese). Ma se la partita è fra “Brasiliani d’Italia”, il terreno di gioco non può che essere quello delle nazionali. E lì vince Conti.
Il mito della superiorità del Brasile era nato in Italia dopo la finale messicana del 1970. Gli eroi del 4-3 alla Germania erano stati annichiliti con disarmante facilità da Pelé e compagni. Quel mito sarebbe stato smontato proprio nel 1982, e non a caso è in questa parentesi, dal ’70 all’82, che si affermano Causio e Bruno Conti.
Dunque, è in quella dozzina d’anni che il “tropicalismo” italico vive la sua stagione d’oro. E se le partite dell’Azteca e del Sarriá hanno avuto il loro peso nell’inaugurare e concludere questa fascinazione esotica, va anche considerato un altro fattore: dal 1966 al 1980 il campionato italiano aveva chiuso le frontiere. Con l’era degli oriundi ormai al tramonto e l’autarchia calcistica imposta dalla figuraccia contro la Corea, gli italiani cercavano insomma di arrangiarsi con dei surrogati locali, come accadeva col caffè in tempi di guerra. Ciò permise di scoprire cultivar nostrane di grande pregio, come si è visto, ma anche esemplari un po’ meno prelibati per i quali l’accostamento ad effetto con la patria del calcio-spettacolo rischia, a distanza di tempo, di sollevare qualche sorriso. Ma tant’è: non si vive di sola qualità oro.
Non Cicoria ma Verza, faceva di cognome il centrocampista veneto che giocò, fra l’altro, nella Juve, nel Milan e nel Verona. La sua fama di brasiliano, oltre che dal genio e dalla sregolatezza (Ilario Castagner l’aveva soprannominato Van Den Bosc per la sua attitudine a scomparire nel corso della partita), derivava forse anche dal suo nome di battesimo: Vinicio. Un nome che evocava, a seconda di gusti e culture, poeti carioca o centravanti di Belo Horizonte naturalizzati partenopei. E a proposito di Napoli, fu lì che Verza siglò il gol più importante della sua carriera, il 17 maggio 1981. Fu un suo tiro (era subentrato nel secondo tempo proprio a Causio) a permettere alla Juventus di espugnare il San Paolo e involarsi verso il suo diciannovesimo scudetto. La sua conclusione di sinistro fu in realtà sporcata da una deviazione di Guidetti, e Verza finì per farsi espellere, a due minuti dalla fine, per perdita di tempo. Ma per un mito minore può andar bene anche così.
Giovanni Roccotelli è invece l’uomo che inventò la rabona. Allora il colpo con le gambe a ics non si chiamava ancora così. Lui da ragazzino lo battezzò “incrociata”, in seguito divenne “cross alla Roccotelli”. Da quel “fondamentale” discese anche una storica frase, a lungo usata nelle redazioni sportive ogni volta che le altre discipline, marginalizzate dal calcio, reclamavano più spazio: “vale più un cross di Roccotelli che tutto il campionato di Basket”. Se fu qualcun altro a eternare il suo cognome, il soprannome brasiliano Roccotelli se l’era trovato da solo: in assonanza con Didì, Vavà e Pelé, per sé scelse Cocò. Potere della rabona (per i brasiliani letra o chaleira) o del bisillabico accentato, leggenda vuole che la stessa Perla Nera, durante un soggiorno in Italia, abbia accennato a Roccotelli. E in tempi più recenti Roberto Bettega gli rese omaggio nel corso di una telecronaca. Ma per un idolo di provincia come lui (Avellino, Cagliari, Ascoli, Cesena, Foggia e Nocerina sono alcune delle squadre in cui ha militato), il riconoscimento migliore forse resta un altro: la scritta su un muretto di tufo in un sobborgo di Taranto, che ha resistito alle ingiurie del tempo e ai propositi di imbiancatura ben oltre la fine della sua carriera agonistica. Diceva semplicemente “Roccotelli sei grande”.
Dopo la vittoria del Mundial, le cose cambiarono. Negli ultimi trent’anni, i fuoriclasse estrosi e quelli leziosi non sono mancati, ma a nessuno è stata attribuita stabilmente un’anima brasileira. Le giocate di un Baggio, di uno Zola, di un Cassano, solo sporadicamente hanno evocato meraviglie verdeoro. E per Donadoni, che pure per talento e ruolo (benché il termine “ala” nel frattempo fosse caduto in disuso) è stato il legittimo erede di Causio e di Conti, nessuno ha mai scomodato suffissi -ão o -inho. Certo, Miccoli è il Romario del Salento, e se proprio vogliamo scandagliare il mare dei soprannomi, ci sarebbe anche Possanzini, che a Reggio Calabria avevano iniziato a chiamare “il Ronaldo dello Stretto”. Ma si tratta significativamente di accostamenti a singoli calciatori più che allo stile di un intero popolo. La verità è che nel calcio di oggi la nazionalità dei giocatori e le distinzioni fra scuole calcistiche hanno perso senso e importanza. Del resto è da tempo che l’Italia non gioca più all’italiana, ed è con uno stile moderno e “internazionale” che ha vinto il suo ultimo mondiale, nel 2006. Ma la verità è anche un’altra: da quando, nella fornace del Sarriá, gli umanissimi azzurri hanno abbattuto dal piedistallo i loro divini avversari, per gratificare un fuoriclasse non c’è più stato bisogno di cambiargli il passaporto. È per questo che Bruno Conti è stato il più grande, e al contempo l’ultimo, dei brasiliani d’Italia.
‘Na sera e maggio di trent’anni fa
 Eppure, nonostante tutto, quando arrivò fu quasi incredulità. Una sensazione troppo grande per poter essere capita, spiegata, pensata come vera. Quei tre fischi furono un lungo, profondissimo brivido in cui tutti ci sentimmo uguali. Poi fu felicità, assoluta e incontenibile, che si sfogò per quasi due ore nel catino ribollente, nel tempio, con gli eroi a fare passerella e il popolo a celebrarli. Dopo, la gioia allagò la città, pronta ad accoglierla con l’abito della festa cucito con pazienza per settimane. E qualcosa di simile accadde in mille altre città del mondo, ovunque ci fosse almeno un tifoso azzurro. Era una dolcissima sera di maggio di venti anni fa, e il Napoli per la prima volta era campione d’Italia.
Eppure, nonostante tutto, quando arrivò fu quasi incredulità. Una sensazione troppo grande per poter essere capita, spiegata, pensata come vera. Quei tre fischi furono un lungo, profondissimo brivido in cui tutti ci sentimmo uguali. Poi fu felicità, assoluta e incontenibile, che si sfogò per quasi due ore nel catino ribollente, nel tempio, con gli eroi a fare passerella e il popolo a celebrarli. Dopo, la gioia allagò la città, pronta ad accoglierla con l’abito della festa cucito con pazienza per settimane. E qualcosa di simile accadde in mille altre città del mondo, ovunque ci fosse almeno un tifoso azzurro. Era una dolcissima sera di maggio di venti anni fa, e il Napoli per la prima volta era campione d’Italia.
Trent’anni fa il Napoli vinceva il suo primo scudetto.
Dieci anni fa, per celebrarlo, usciva ‘Na sera ‘e maggio.
La stanza profonda di Vanni Santoni
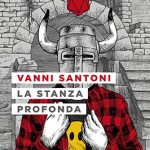 Clicca qui per leggere la recensione di La stanza profonda, l’ultimo libro di Vanni Santoni, fra i 12 finalisti del Premio Strega 2017.
Clicca qui per leggere la recensione di La stanza profonda, l’ultimo libro di Vanni Santoni, fra i 12 finalisti del Premio Strega 2017.
Articolo pubblicato sul Quotidiano di Puglia del 4 aprile 2017.
Mafia Caporale
 Clicca qui per leggere la recensione di “Mafia Caporale” (Fandango), il reportage di Leonardo Palmisano sulle schiavitù in Italia. L’articolo è stato pubblicato sul Quotidiano di Puglia dello scorso 1 aprile.
Clicca qui per leggere la recensione di “Mafia Caporale” (Fandango), il reportage di Leonardo Palmisano sulle schiavitù in Italia. L’articolo è stato pubblicato sul Quotidiano di Puglia dello scorso 1 aprile.
Il video dell’evento di Torino
18 marzo: Taranto Day on Tour a Torino
 Sabato 18 marzo Giuliano interverrà alla tappa torinese del Taranto Day on Tour, l’iniziativa di calcio e cultura organizzata dalla Fondazione Taras. Con lui, fra gli ospiti, il cantautore Mimmo Cavallo, lo scrittore Cosimo Argentina e gli ex calciatori del Taranto Sergio Giovannone e Vincenzo Chiarenza. Appuntamento a Torino presso l’Auditorium della Parrocchia San Giorgio Martire in via Anton Giulio Barrili 12. Porte aperte dalle 15. L’intervento di Giuliano, che leggerà alcuni passi dei suoi libri, è previsto intorno alle 19.
Sabato 18 marzo Giuliano interverrà alla tappa torinese del Taranto Day on Tour, l’iniziativa di calcio e cultura organizzata dalla Fondazione Taras. Con lui, fra gli ospiti, il cantautore Mimmo Cavallo, lo scrittore Cosimo Argentina e gli ex calciatori del Taranto Sergio Giovannone e Vincenzo Chiarenza. Appuntamento a Torino presso l’Auditorium della Parrocchia San Giorgio Martire in via Anton Giulio Barrili 12. Porte aperte dalle 15. L’intervento di Giuliano, che leggerà alcuni passi dei suoi libri, è previsto intorno alle 19.
La quarta edizione di Inchiostro di Puglia!
 Inchiostro di Puglia, l’antologia di racconti pugliesi nata da un singolare esperimento dal basso, è arrivata alla sua quarta edizione, che si fregia di una nuova copertina con fondo bianco anziché azzurro. Il libro, firmato da oltre trenta fra i più interessanti autori pugliesi, si apre con l’incipit di “13 sotto il lenzuolo”, secondo romanzo di Giuliano, e contiene il suo racconto “Genius loci”. Lo si trova nella rete delle librerie aderenti al progetto e online esclusivamente sul sito dell’editore Caracò.
Inchiostro di Puglia, l’antologia di racconti pugliesi nata da un singolare esperimento dal basso, è arrivata alla sua quarta edizione, che si fregia di una nuova copertina con fondo bianco anziché azzurro. Il libro, firmato da oltre trenta fra i più interessanti autori pugliesi, si apre con l’incipit di “13 sotto il lenzuolo”, secondo romanzo di Giuliano, e contiene il suo racconto “Genius loci”. Lo si trova nella rete delle librerie aderenti al progetto e online esclusivamente sul sito dell’editore Caracò.


