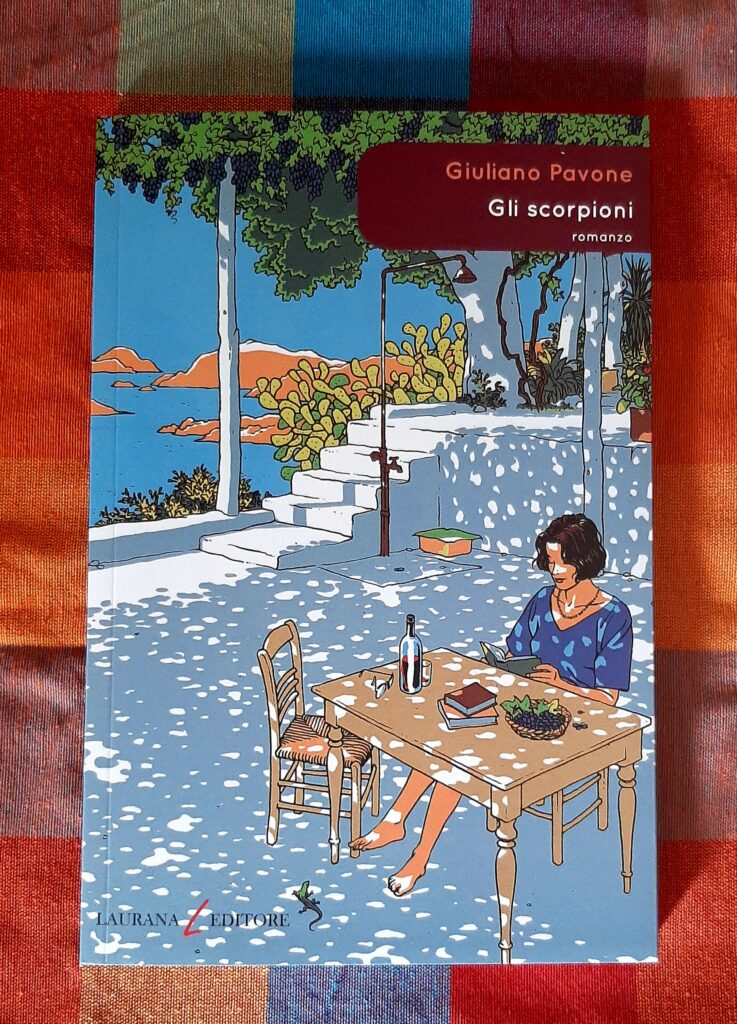MARADONA, L’ANTIEROE DI MILANO
Per capire davvero cosa fosse Maradona per il calcio e il calcio per Maradona bisognava essere a San Siro il pomeriggio del 12 novembre 1988. Nazionale di Lega di Serie A contro Polonia.
E invece eravamo in pochi, giusto qualche migliaio. Scarsa la pubblicità e ancora minore l’empatia per un progetto che visse un periodo di relativa gloria fra ’60 e primi ’70 per poi venire riproposto proprio in quell’occasione e infine essere accantonato dopo appena un altro match, nel ’91. L’idea della Nazionale di Lega era bizzarra ma affascinante: una rappresentativa non dei migliori calciatori italiani ma dei migliori calciatori – italiani e stranieri – militanti nel nostro campionato. Quasi un tentativo di riaffermare sul campo quel titolo platonico di “campionato più bello del mondo” che ci eravamo autoassegnati ma che nessuno, allora, poteva permettersi di mettere in dubbio.
Quel pomeriggio San Siro offriva uno spettacolo lunare: nudo di copertura, terzo anello e seggiolini, semideserto, reso ancora più scheletrico e precario dai lavori in corso in vista di Italia 90. Il secondo anello, uno scabro nastro di cemento privo di divisioni fra settori, era macchiato qua e là da sparuti gruppi di spettatori in cui si distinguevano solo tre assembramenti un po’ più corposi: al centro delle due curve gli interisti e i milanisti e, a metà del lato lungo, in corrispondenza della linea di centrocampo, quasi come in una terza curva, i napoletani.
Apparivano così isolate – in quell’atmosfera rarefatta, quasi da laboratorio – le tre comunità di tifosi più presenti a Milano (gli juventini erano meno numerosi di adesso, o forse solo meno visibili). E anche le tre squadre che stavano facendo grande il calcio italiano, con il Napoli – immortalato nel punto di equidistanza fra i suoi due scudetti – che a fine stagione si sarebbe unito ai trionfi delle milanesi aggiudicandosi la Coppa Uefa.
Idea bizzarra ma affascinante, dicevamo, la Nazionale di Lega. Oggi dimenticata, ma da ricordare se non altro per le tante circostanze più uniche che rare. La prima e (ovviamente) unica volta di Maradona con una maglia dell’Italia. La prima e unica volta di Maradona compagno di squadra di Matthäus. La prima e unica volta di Maradona agli ordini di Sacchi. Sì, il “selezionatore” di quella strana nazionale era proprio Arrigo da Fusignano, legato a Diego da un rapporto di reciproca stima a dispetto dell’acerrima rivalità che opponeva i rispettivi club. E Sacchi per l’occasione mise insieme una compagine molto eterogenea, in cui si mischiavano grandi campioni, ottimi giocatori e diverse mezze figure. Fra i grandi campioni, oltre ai due già citati, anche Careca. Non, invece, il trio delle meraviglie olandese-milanista, chissà se per il nobile intento di sottrarsi a una sorta di conflitto di interessi o per un più prosaico desiderio di preservarli da una fatica inutile in vista del campionato.
La partita inizia e scorre via svogliata. Sugli spalti i tre gruppetti di tifosi continuano a inneggiare alle rispettive squadre e si sfottono blandamente fra loro. I napoletani invocano Diego. In campo l’“Italia” è distratta, spaesata. In fondo è gente che gioca insieme per la prima volta, e sembra chiedersi il senso di quella strana partita in un pomeriggio infrasettimanale. La Polonia invece è una squadra vera, rodata, ed è animata dallo stakanovismo granitico di tutte le nazionali dell’Est prima della caduta del Muro. Così, gli ospiti passano in vantaggio. Solo allora gli azzurri si risvegliano. Tassotti in posizione centrale serve Maradona al limite. Con un controllo orientato Diego si libera del proprio marcatore e infila un corridoio libero, mettendo il difensore rossonero davanti al portiere e consentendogli di pareggiare. Maradona corre a festeggiarlo, lui ricambia appena.
La partita riprende la sua routine blanda, rischiarata di tanto in tanto da qualche colpo di classe. Nel secondo tempo però la Polonia passa di nuovo in vantaggio, e dopo coglie pure un palo. È andata così, sembrano dire un po’ tutti, a quel punto. Nessuno ha più la forza né la voglia di abbozzare una reazione. Nessuno tranne Maradona. El Pibe decuplica gli sforzi: va a prendere palloni nelle retrovie, piazza scatti per smarcarsi, si sbraccia con i compagni per chiamare il pressing o suggerire giocate. Non ci sta a perdere. Vuole almeno pareggiarla, anche se non conta niente. E alla fine ci riesce, di classe e prepotenza: dribbling secco, triangolazione casuale con un avversario, stop di petto, esterno sinistro al volo sul primo palo ed esultanza in stile Mexico 86.
Maradona era questo. Maradona è questo, anche adesso, quando gioca col nipotino. Una partita è una partita. Va onorata e vinta, indipendentemente dalla posta in palio. Un rispetto sacrale per il calcio, il suo, inversamente proporzionale a quello avuto per se stesso e per il proprio mito. “La pelota no se mancha” disse in lacrime alla Bombonera il giorno del suo addio. La palla non si sporca. Era invece disposto a sporcarsi lui, con la palla, non solo metaforicamente, come in un’azzeccatissima immagine che gli dedicò Osvaldo Soriano: se, in smoking a un pranzo di gala gli piovesse addosso un pallone infangato, lo stopperebbe di petto senza alcuna esitazione. O come ad Acerra, in un pantano ignobile, fra compagni e avversari quasi imbarazzati per lui, presente per beneficienza in un’altra delle sue partite meno conosciute eppure più emblematiche.
Maradona, a Milano, lo odiavano. Come in buona parte dell’Italia, ma forse anche un po’ di più. “Maradona figlio di puttana”, gli cantavano a San Siro sulle note di “Alouette”, e poi fischi a ogni tocco di palla oltre ai consueti cori razzisti antinapoletani, all’epoca non ancora codificati nella pavida formula “discriminazione territoriale”. Perché lo odiavano? Non era solo la paura e l’invidia per il più forte che viene a giocare da avversario, con la maglia di una squadra rivale. Non era solo per le sue spacconate, per i suoi atteggiamenti da capopopolo (“Non voglio vedere neanche una bandiera rossonera al San Paolo”, aveva detto pochi mesi prima, e non gli era andata bene). Il fatto è che Maradona era Napoli. E Napoli era la sua patria, adottiva ma anche elettiva, e per questo forse ancora più vicina al cuore di quella naturale. Un’identificazione, anzi un reciproco riconoscersi, fra città e giocatore senza precedenti nella storia del calcio.
Milano era altro. Milano era tutto il contrario. L’opposizione era culturale, filosofica, politica, antropologica. Si riaccendevano negli stadi i mai sopiti pregiudizi, che da lì a pochi anni avrebbero trovato sfogo negli exploit della Lega, allora solo Lombarda. A ciò poi si aggiungeva un discorso squisitamente calcistico, in cui il Napoli recitava la parte del parvenu nel consesso dell’aristocrazia, vestita esclusivamente a strisce verticali. Che il Napoli avesse vinto uno scudetto, fosse entrato stabilmente nel giro delle squadre di vertice e avesse addirittura fra i suoi il più grande di tutti, visto dai gradoni della Scala del Calcio era qualcosa di semplicemente inaccettabile.
Ci avrebbero messo tanto, i milanesi, a perdonargli quel delitto di lesa maestà e ad ammettere apertamente – non solo nelle segrete conversazioni fra compagni di fede – la sua grandezza. Anni dopo il suo addio al Napoli, e anche successivamente al suo ritiro, nei bar meneghini, fra un marocchino e una Gazzetta sfogliata sul frigo dei gelati, si poteva sentir affermare con la massima serietà che “son capaci tutti a giocare bene dopandosi”. Solo in tempi molto più recenti – con Maradona in città proprio per un’iniziativa della Gazzetta – gli riservarono un’accoglienza da star, sinceramente affettuosa. Ormai il rivale era innocuo, e la cronaca si era trasformata in Storia. Ma chissà, dietro quell’accoglienza c’era forse anche il rispetto per un uomo che ha compiuto molti errori e li ha pagati tutti.
Maradona era Napoli. Maradona non avrebbe mai potuto giocare in un’altra squadra italiana. Ma se, per pura ipotesi ucronica, l’avesse fatto? Con chi avrebbe potuto? Con la Juve no: è troppo anche per un gioco di immaginazione. Restano le milanesi. Se – Miracolo a Milano – fosse approdato sotto la Madonnina, a quale sponda avrebbe attraccato? La risposta più sensata è: a quella rossonera. Diverse le affinità fra Diego e quel Milan, sospeso fra orgoglio proletario casciavit e grandeur da nuovi ricchi. E poi la vocazione al gioco spettacolare – della stima reciproca con Sacchi si è già detto – e la stessa scelta di campo effettuata con gli stranieri: atletici, sì, ma dotati anche di classe e fantasia, e due su tre di origini sudamericane. Più difficile invece immaginare un Maradona ben inserito in quell’Inter trapattoniana e mitteleuropea, sparagnina nel gioco, teutonica nello stile, nonostante la presenza di Ramón Díaz, che nel 1979 era stato partner di Maradona nel vittorioso Mondiale Under 20 in Giappone, in quella che Diego ha spesso definito la più forte Argentina in cui abbia giocato.
Le danze fra il Napoli e le milanesi, in quel Campionato 1988-89, si aprono al San Paolo il 27 novembre, ospiti i rossoneri. Sono passati quasi sette mesi dal 2-3 che sancì il sorpasso del Milan e la rinuncia degli azzurri a uno scudetto che solo qualche settimana prima sembrava già conquistato. Nel tempo trascorso fra l due partite ci sono stati una rivolta dei calciatori contro l’allenatore Ottavio Bianchi, con successiva epurazione dei ribelli (Bagni, Ferrario, Garella e Giordano) e un nuovo torneo iniziato a suon di gol (8-2 al Pescara e, proprio la domenica precedente al match contro il Milan, un pirotecnico 5-3 rifilato alla Juventus a Torino). La vendetta si consuma pienamente: finisce 4-1 per il Napoli, con tre gol in pochi minuti a cavallo dei due tempi e la difesa rossonera sistematicamente infilata in contropiede o eludendo il suo fuorigioco alto. Memorabile soprattutto la prima marcatura: su lancio di Crippa, Maradona beffa la linea difensiva che sale e si trova solo davanti a Giovanni Galli in uscita. Diego lascia rimbalzare il pallone e, pur abbondantemente fuori area, lo colpisce di testa, prendendo in controtempo il portiere avversario. La sfera rimbalza due volte, quasi beffarda, prima di adagiarsi con dolcezza in rete. Anche il secondo gol vede la partecipazione attiva di Maradona, questa volta con un assist per Careca, e di nuovo di testa, quasi che l’argentino abbia voluto celebrare l’occasione speciale con il pezzo meno consueto del suo immenso repertorio.
Non ci sarà al ritorno, Maradona, il 9 aprile 1989, in uno 0-0 che segue di pochi giorni un mercoledì di coppa e di una settimana la sconfitta interna contro la Juve che allontana il Napoli dall’Inter capolista. C’è, invece, in entrambe le sfide contro i nerazzurri. Il 15 gennaio (tredicesima giornata) al San Paolo finisce a reti bianche, dopo un primo tempo combattuto ed equilibrato e una ripresa di inutili attacchi partenopei (traversa di De Napoli). Il 28 maggio 1989 (trentesima giornata) si gioca al Meazza la partita decisiva per l’assegnazione del campionato. Il Napoli onora l’impegno, e mette paura agli avversari passando in vantaggio con uno splendido gol di Careca. Ma, alla fine di una partita resa avvincente anche dai pali di Díaz e dello stesso Careca, è l’Inter a imporsi, ribaltando il risultato, prima con un tiro di Berti deviato da Fusi, e poi con una punizione di Matthäus. Giusto così: l’Inter si aggiudica lo scudetto dei record battendo la squadra che le si arrende per ultima. A fine stagione il Napoli separerà le due milanesi nella classifica del Campionato, e si unirà a loro nella grande festa del calcio italiano aggiungendo la propria Coppa Uefa a quella del Campioni conquistata dal Milan. D’altra parte, gli scudetti meneghini di fine anni 80 (Milan ’88 e Inter ’89) sono racchiusi come fra parentesi dai due titoli partenopei. Napoli terzo incomodo fra Inter e Milan, quindi, e Maradona antieroe di Milano. Anti, ma pur sempre eroe.